Emisferectomia e decorso postoperatorio
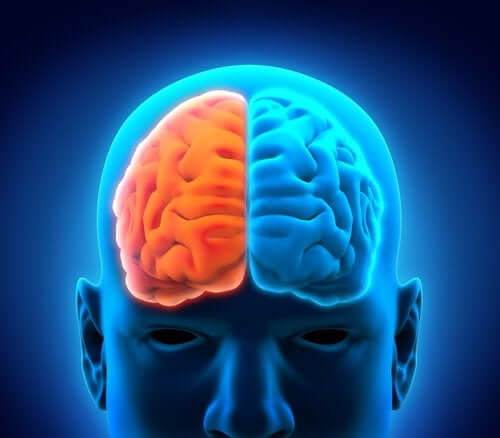
L’emisferectomia è una procedura chirurgica mediante la quale si trattano diversi disturbi convulsivi. Si ricorre a essa quando le patologie non rispondono adeguatamente ad altri trattamenti meno invasivi.
Sembra che la prima emisferectomia venne praticata nel 1888 a un cane. Il primo riferimento di questa delicata procedura realizzata su umani risale al 1923. Negli anni ’60 e ’70, se ne realizzarono diverse, con risultati poco promettenti.
Attualmente, l’emisferectomia tradizionale viene spesso sostituita da quella funzionale, un’operazione molto più precisa e meno invasiva. La percentuale di successo è molto più elevata rispetto al passato.
Che cos’è l’emisferectomia?

L’emisferectomia è una procedura neurochirurgica che consiste nell’estirpazione di uno dei due emisferi cerebrali. A volte si rimuove l’emisfero sinistro, mentre in altre occasioni quello destro. Quest’operazione viene realizzata soprattutto su bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni.
Si ricorre a questo tipo d’intervento soprattutto come trattamento anti-convulsivo. Tuttavia, si può consigliare anche per determinati pazienti con un deficit neurologico ed, eccezionalmente, in casi di trauma cranico grave.
Anche se la procedura tradizionale prevede l’estirpazione di tutto l’emisfero, talvolta è sufficiente rimuoverne solo una parte. Quando ciò accade, si parla di emisferectomia funzionale. In questi casi, se si lascia anche una minima porzione del tessuto danneggiato, il disturbo convulsivo può presentarsi di nuovo.
Indicazioni

In linea generale, l’emisferectomia è indicata in caso di crisi convulsive continue e quotidiane e che non hanno risposto al trattamento farmacologico o ad altri interventi chirurgici meno invasivi.
Scoprite anche: Jaxon Buell: il bambino nato senza una parte del cervello
Quest’intervento chirurgico è indicato nei seguenti casi:
- Paralisi cerebrale infantile. Solo nel caso di bambini di età superiore ai 4 anni, che presentano disturbi convulsivi e mentali e dopo aver verificato che il paziente non risponde al trattamento farmacologico per due anni consecutivi.
- Sindrome di Sturge-Weber. È un disturbo neurocutaneo caratterizzato dalla presenza di una macchia facciale nell’area del nervo trigemino. Si consiglia l’intervento quando le crisi iniziano in età molto precoce e il disturbo riguarda l’intero emisfero.
- Sindrome di Rasmussen. È un disturbo che genera un’encefalite cronica e progressiva. Si consiglia di operare il prima possibile.
- Megalencefalia monolaterale. È una malattia neurologica infiammatoria rara, caratterizzata da convulsioni severe. L’efficacia dell’operazione per i pazienti affetti da questa malattia è ancora fonte di dibattito.
- Anomalie dello sviluppo corticale. Solo quando le malformazioni emisferiche sono unilaterali.
Caratteristiche della procedura chirurgica
Esistono quattro modalità di emisferectomia, ma in tutti i casi gran parte del successo dipende dal controllo dell’emostasia. Le quattro modalità sono:
- Emisferectomia anatomica.
- Emidecorticazione.
- Emisferectomia funzionale.
- Emisferectomia funzionale modificata.
La procedura tipica viene realizzata sotto anestesia totale. Si inizia rasando la testa del paziente e segnando delle linee di incisione. Poi si procede al taglio, lasciando esposta la dura madre, che viene rimossa per lasciare esposto il cervello.
Con il cervello esposto, si delimita la zona che va estirpata. La si estirpa, si cauterizzano i vasi sanguigni e si colloca un drenaggio. In seguito, si riposizionano tutti gli strati che sono stati spostati, ovvero la dura madre, l’osso e il cuoio capelluto. L’incisione viene suturata con delle graffette.
Il decorso postoperatorio dell’emisferectomia
Il decorso postoperatorio di questa operazione è molto doloroso. In genere, il drenaggio viene mantenuto per 3 o 4 giorni, prima di valutare se è il caso di rimuoverlo. In ogni caso, prima di toglierlo, è molto importante realizzare gli esami diagnostici del caso per stabilire se c’è ancora sanguinamento o emorragia.
Le principali complicazioni dell’immediato postoperatorio sono legate all’instabilità emodinamica, all’ipotermia e all’ipo- o iperpotassemia. Di solito sono tutte condizioni che vengono controllate con successo nell’Unità di Terapia Intensiva.
La comparsa di convulsioni nel periodo postoperatorio è considerata una complicazione grave. Circa la metà dei pazienti presenta idrocefalia e quasi tutti sviluppano una meningite asettica. Il tasso di mortalità oscilla fra il 4-6%.
Leggete anche: Meningite: cause, sintomi e trattamento
Fra il 70-85% dei pazienti sottoposti a emisferectomia riesce a controllare le crisi convulsive. Intorno al 10-20% vede un significativo miglioramento delle proprie condizioni. Tuttavia, alcune delle complicazioni legate a quest’intervento possono comparire tardivamente.
Tutte le fonti citate sono state esaminate a fondo dal nostro team per garantirne la qualità, l'affidabilità, l'attualità e la validità. La bibliografia di questo articolo è stata considerata affidabile e di precisione accademica o scientifica.
- Obrador Alcalde, S. (1951). Hemisferectomía en el tratamiento de las convulsiones de la hemiplejía infantil por hemiatrofía cerebral. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 9(3), 191-197.
- Alcalá-Cerra, G., Paternina-Caicedo, Á., Díaz-Becerra, C., & Gutiérrez-Paternina, J. J. (2013). Control de las crisis epilépticas con la hemisferectomía cerebral en adultos: revisión sistemática y metaanálisis con datos de pacientes individuales. Neurocirugía.
- Meneses, M. S. de, Kondageski, C., Santos, H. N. L. dos, Kowacs, P. A., Coelho, G. C., Gadens, G., … Simão, C. (2012). The usefulness of neuronavigation in functional hemispherectomy. Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology.
Questo testo è fornito solo a scopo informativo e non sostituisce la consultazione con un professionista. In caso di dubbi, consulta il tuo specialista.








